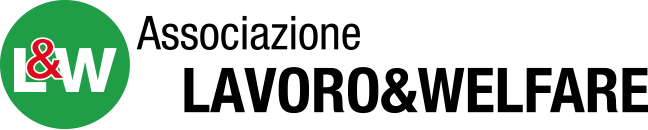Foto di Colin Lloyd su Unsplash
Costituzione, cantiere permanente
di Paolo Casali, Direttivo Lavoro&Welfare
Se sono in crisi le democrazie parlamentari tanto quanto quelle presidenziali e semipresidenziali e se non se la passano tanto bene nemmeno diverse monarchie “democratiche”, forse il problema è più profondo e non basta la riscrittura di quattro o più articoli di una Costituzione
Il dibattito sulle riforme istituzionali ritorna con ciclica regolarità ogni qualvolta si profila una nuova stagione politica.
È stato così con la crisi dei partiti della cosiddetta prima repubblica e la drammatica fase del post tangentopoli. Con la prima affermazione della coalizione delle destre a trazione berlusconiana, così come in occasione dei molteplici tentativi – con esiti incerti – di costruzione della coalizione delle forze progressiste. Se una peculiarità può essere rintracciata negli ultimi due tentativi – quello abortito della stagione renziana e quello annunciato dall’attuale maggioranza meloniana – essa è nella volontà di costruire un nuovo assetto istituzionale funzionale alle specifiche leadership che congiunturalmente si trovavano o si trovano alla testa delle coalizioni vincenti elettoralmente.
In ogni occasione, tuttavia, la sensazione che ne è scaturita è che la fantasia dei costituzionalisti di turno fosse stata mobilitata per escogitare soluzioni istituzionali e congiuntamente elettorali, al fine di colmare il vuoto della proposta politica.
Una caratteristica peculiare del progetto meloniano è quella di voler operare una cesura netta e definitiva con il modello di governo delineato dai padri costituenti, di chiara matrice antifascista. Un modello e un’ispirazione rispetto alla quale la destra, che si identificava e tutt’ora si richiama alla fiamma tricolore, si è sempre sentita, ovviamente, estranea.
Se questi sono i presupposti, dovrebbero essere altrettanto chiari e fermi i termini per il posizionamento di chi non è disponibile a rinunciare ai princìpi che hanno ispirato la carta del 1948. I quali dovrebbero, anzi, ambire a portarne a compimento tutti i profili che caratterizzano il progetto sociale e democratico e che ne sono i fondamenti morali.
In molta parte della pubblicistica e, per osmosi, nel dibattito interno alle forze progressiste, quando si affronta il tema delle riforme istituzionali si è soliti premettere la costatazione della “crisi” delle democrazie su entrambe le sponde dell’atlantico e non solo. La si butta là, quasi fosse un refrain per favorire l’acclimatazione degli interlocutori.
Ma se davvero si prendesse sul serio tale dato, si dovrebbe farne discendere conseguenze ben più gravi. Invece si passa subito a lambiccare se il potere di nomina dei ministri vada rivisto e se sia meglio distinguere il ruolo delle due camere e la loro diversa forma di rappresentanza o tecnicalità del genere.
Se sono in crisi le democrazie parlamentari (Italia, Grecia), tanto quanto quelle presidenziali (Usa – Trump, Brasile – Bolsonaro, Argentina – Milei), semipresidenziali (Francia – Macron) e se non se la passano tanto bene nemmeno diverse monarchie “democratiche”, forse il problema è più profondo e non basta la riscrittura di quattro o più articoli di una Costituzione. Forse non ci sono modelli da riversare, chiavi in mano, sulle nostre Istituzioni e sulla nostra realtà sociale.
Uno degli argomenti che va per la maggiore, quando si parla di riforme istituzionali, è rappresentato dalla necessità della velocità delle decisioni. Il mantra è che la globalizzazione, le guerre, le crisi finanziarie, le pandemie e altre incombenze di varia natura necessitano di decisioni tempestive, immediate, subitanee che mal si conciliano con la farraginosità del metodo assembleare rappresentativo. Quindi va cambiata la costituzione che ruota intorno al pilastro del Parlamento.
Nel corso degli ultimi 20 anni abbiamo assistito al dilagare della decretazione d’urgenza e a un parossismo legislativo, con una iperproduzione normativa. Il risultato non sembra soddisfacente per nessuno. I nodi strutturali sono rimasti quasi del tutto irrisolti. Quasi nessuna delle riforme strutturali è stata approntata con norme la cui correzione è fallita, integrate e rimaneggiate più e più volte. Con un conseguente deterioramento della qualità della legislazione, della certezza del diritto e della stessa capacità di cittadini, amministrazioni e imprese di potersi districare nel ginepraio che sgorga dalla Gazzetta Ufficiale.
Un altro tema che viene riproposto per giustificare la necessità di cambiare l’impianto costituzionale è quello che fa riferimento alla stabilità dei governi. Quindi, si propongono nuove regole per irrigidire il quadro politico, al punto da garantire la sopravvivenza degli esecutivi anche a fronte del venir meno delle ragioni della coesione politica tra i sottoscrittori del patto di Governo. Ma, come noto, anche all’interno del medesimo partito si possono innescare dinamiche centripete e determinare frazioni e scissioni. Immaginare di poter imbrigliare le dinamiche politiche, quando genuinamente derivanti da altrettante dinamiche sociali, appare una illusoria scorciatoia che non offrirebbe alcuna reale garanzia per la continuità dell’azione di governo.
Ma se tutte le democrazie stanno attraversando una fase di affaticamento della propria credibilità e del radicamento nel sentire di ampi strati sociali – fenomeno che si manifesta più direttamente nella disaffezione del voto e nel distacco dalla politica – tali dinamiche andrebbero studiate più seriamente, cercando di individuarne le cause scatenanti.
Intanto, bisognerebbe partire dalla costatazione di un dato di fatto. A decorrere dagli anni 90, nel blocco delle democrazie di stampo occidentale, qualunque fosse la forma di stato o di governo, è venuta accentuandosi la polarizzazione sociale. Ciò, con una tendenza costante, i cui picchi si sono sommati in concomitanza con le ricorrenti crisi finanziarie, belliche o sanitarie. Le esigue minoranze dei più ricchi hanno accumulato crescenti patrimoni e influenza sui decisori politici, mentre strati sempre più vasti di popolazione venivano trascinati verso la povertà, verso l’incertezza materiale ed esistenziale e l’irrilevanza politica. Un esito che è stato il frutto della casualità? Difficile sostenerlo credibilmente.
La realtà è che non si può non collegare questi processi alle mosse strategiche che furono adottate in ossequio del neoliberismo degli anni 70 e 80: dall’abbandono della parità aurea alla derugalation thatcheriana e reaganiana, con il corollario della libera circolazione dei capitali e la finanziarizzazione dell’economia.
Una strategia che ha anche accelerato il collasso del blocco sovietico, ponendo fine al “sogno”, per alcuni, o alla “minaccia”, per gli altri, di un modello istituzionale, economico e sociale alternativo a quello occidentale.
Grazie a tali condizioni è, di fatto, venuto meno il contratto sociale che stava alla base delle nostre costituzioni. Uno dei contraenti – il capitale – si svincolava dal sistema delle regole costituzionali e sceglieva liberamente dove allocarsi e a quali regole obbedire, tra quelle offerte dai diversi paesi. Saltava quindi quell’equilibrio che rendeva sostenibile un generoso Welfare State.
Una siffatta analisi si espone sicuramente all’accusa di “complottismo” da parte dei tanti Candide che alimentano il dibattito pubblico.
Tuttavia, giova ricordare le parole con le quali la famosa agenzia di rating JP Morgan, nel maggio 2013, analizzò i tratti caratterizzanti delle costituzioni di alcuni dei Paesi che si erano liberati dalla tirannide nazi-fascista: “nei primi momenti della crisi si è pensato che i problemi nazionali ereditati dal passato fossero in gran parte economici: debiti eccessivi di Stato, aziende e famiglie, disallineamenti dei cambi reali interni, rigidità strutturali. Ma, nel tempo, è diventato chiaro che ci sono anche problemi politici ereditati dal passato. Le costituzioni e le strutture politiche della periferia meridionale, messa in piedi dopo la caduta del fascismo hanno numerosi aspetti che sembrano essere inadeguati all’ulteriore integrazione dell’area […] le costituzioni tendono a mostrare una forte influenza socialista, che riflette la forza politica goduta dai partiti di sinistra dopo la sconfitta del fascismo. I sistemi politici della periferia tipicamente mostrano diversi dei seguenti aspetti: deboli esecutivi, deboli Stati centrali rispetto alle Regioni, protezione costituzionale dei diritti del lavoro, sistemi di costruzione dei consensi che alimentano il clientelismo politico, e il diritto a protestare se sono realizzati cambiamenti politici allo status quo non apprezzati. I paesi alla periferia sono stati solo parzialmente capaci di realizzare riforme economiche e fiscali, con i governi vincolati dalle costituzioni (Portogallo), da potenti regioni (Spagna), e dall’emergere di partiti populisti (Italia e Grecia)”.
Certamente non si può far tornare indietro la ruota della storia, ma non tenere conto di certe dinamiche e condizioni strutturali rischia di trasformare tutto il dibattito sulle regole costituzionali e sulla tenuta stessa delle nostre democrazie in uno sterile esercizio di stile.