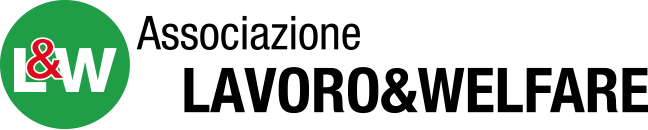Previdenza


di Anna Giacobbe
La sovrapposizione tra contrasto alla povertà e politiche attive per il lavoro ha generato un sistema per accedere al Reddito di cittadinanza davvero sbagliato. Chi fa domanda e riceve il sussidio, viene inviato al Centro per l’Impiego oppure ai servizi sociali dei Comuni; il primo percorso per i più giovani e disoccupati da minor tempo, il secondo per i più anziani e più “sfortunati”
Un reddito minimo garantito, sufficiente a fare uscire tutte le persone in povertà assoluta da quella condizione, ci deve essere, e deve essere collegato a interventi di accompagnamento, responsabilizzazione, inclusione sociale attiva.
Per realizzare una misura di questo tipo sono necessari 7,1 miliardi (5,5 per i contributi; 1,6 per il sostegno ai servizi), secondo la proposta per il Reddito di Inclusione Sociale – Reis – sostenuta dall’Alleanza contro la Povertà, composta da 35 organizzazioni, tra realtà associative, rappresentanze dei Comuni e delle Regioni, enti di rappresentanza del terzo settore, e sindacati.
Il finanziamento previsto per il “reddito di cittadinanza” (Rdc) è dunque adeguato; non è questo il punto della discussione.
Si finanzia “a debito”, si spendono soldi che non ci sono? È un problema che riguarda l’insieme della manovra economica approvata con la Legge di Bilancio 2019. Un problema serio; ma dire che si spendono troppi soldi per contrastare la povertà assoluta sarebbe sbagliato.
A proposito di risorse, c’è una questione che vale la pena di ricordare. La Ragioneria Generale dello Stato pretese con molta “determinazione” per il reddito di inclusione (Rei), creato con la legge 33/2017, delle ipotesi sul numero dei destinatari del tutto sopravvalutate, che comportarono la previsione di requisiti ben più restrittivi del necessario: ora, nella relazione tecnica al decreto sul reddito di cittadinanza, quei conti vengono definiti “eccessivamente prudenziali”; anzi, si ammette la realtà opposta, “tenuto conto anche che nelle rassegne internazionali disponibili” (disponibili da ora?), e cioè che non tutti i destinatari teorici chiederanno il Rdc. E così, nel 2018 si è speso per il reddito di inclusione meno di un miliardo di euro, mentre ne erano disponibili 1,747.
Poco importerebbe, se non ci fossero conseguenze molto concrete sulla vita delle persone. Le domande presentate al 30 settembre 2018 erano 787.982; alla stessa data le domande accolte risultavano 375.799; delle 354.553 domande rifiutate, per oltre 300mila la motivazione è stata il superamento (in molti casi di poco) dei limiti di ISEE o di reddito previsti. Chi si è visto respingere la domanda (mentre i denari per rispondere positivamente ci sarebbero stati) probabilmente ha anche ricevuto dallo Stato una delusione, che non meritava.
Va considerato anche un altro aspetto: il Rdc, così come già il Rei, integra il reddito sino ad una certa soglia, ma prevede un requisito di accesso precedente (vincolante) basato sull’ISEE, una misura di tutt’altra natura, calcolata tenendo conto di diversi altri fattori; per di più si usano scale di equivalenza differenti, tra ISEE e parametrazione del Rdc al numero di componenti del nucleo familiare.
Proprio perché le risorse disponibili sono oggi maggiori, è importante non usarle male e fare tesoro dell’esperienza compiuta con il Rei; insomma non ricominciare tutto da capo con le procedure, le verifiche, la burocrazia.
Cgil, Cisl e Uil, l’Alleanza contro la Povertà, le Regioni, le associazioni dei disabili, hanno espresso obiezioni e chiesto modifiche al decreto. È ancora possibile che tutte queste forze, rappresentative e competenti, riescano ad ottenere cambiamenti al decreto n. 4, e non solo in qualche dettaglio?
Vediamo le questioni più rilevanti. Il limite del Rei è stato, oltre alla quantità insufficiente di risorse, una serie di difficoltà applicative che solo di recente si stavano superando. Certamente “ricominciare da capo” con il Reddito di cittadinanza creerà altri problemi analoghi: questo deve essere evitato.
Per altro, il fatto che il Rdc sia una misura “in continuità” rispetto al “reddito di inclusione” è confermato in molti aspetti della norma e in molti passaggi della Relazione tecnica che l’accompagna.
Il Governo insiste molto sulla discontinuità tra i due provvedimenti. Se riguardasse l’immagine, poco male: sarebbe anche comprensibile. Ma c’è altro.
L’Alleanza contro la Povertà ha scritto che una totale discontinuità rispetto al REI “a livello locale, porterebbe il caos… si azzererebbe il lavoro svolto faticosamente sinora… si assegnerebbero ai Centri per l’Impiego compiti di cui, oggi, non sono in grado di farsi carico”.
Ci sono diversi atti che richiedono del tempo (Decreti Ministeriali, intese in sede di Conferenza Stato Regioni, convenzioni con i Caaf, predisposizione da parte dei Comuni delle procedure amministrative per i progetti utili alla collettività, ecc.). Nell’impianto del Rdc, le piattaforme digitali hanno un ruolo fondamentale; è necessario che funzionino alla perfezione. Uno dei problemi di attuazione del Rei è stata la comunicazione tra Comuni e Inps, sia per l’invio delle domande, procedura piuttosto semplice, sia per la gestione delle sospensioni e riattivazioni, sia per altre modifiche nella dichiarazione del possesso dei requisiti. Un faticoso lavoro di verifica e relazione tra Comuni e Inps sta pian piano affrontando questa criticità. Chi garantisce che questi problemi non si ripresenteranno con il Rdc, e non ci vorrà comunque un periodo di rodaggio?
Tutto ciò consiglierebbe di evitare un brusco salto tra Rei e Rdc. Questo è un primo punto su cui intervenire con modiche al decreto n.4 nel corso dell’iter parlamentare.
Altro elemento importante: il Rdc viene definito innanzitutto “misura fondamentale di politica attiva del lavoro”, e poi “di contrasto alla povertà”, “volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione”. Questo diritto riguarda tutti, non solo quelli che vivono in una famiglia in condizioni di povertà. Pur essendo diverse le opportunità delle persone a seconda della condizione socio-economica e del contesto familiare, le barriere per l’accesso la lavoro non dipendono solo da quella.
L’assegno di ricollocazione, una sorta di “dote” per pagare il supporto che una persona può ricevere dai Centri per l’Impiego o altri soggetti per trovare un nuovo lavoro, viene riservato a chi riceve il Rdc, escludendo le persone che ne hanno avuto diritto sino ad ora (chi percepisce ammortizzatori sociali). Si vede anche da questo come la commistione tra contrasto alla povertà e politiche attive del lavoro possa produrre fatti negativi e conflitti “tra gli ultimi e i penultimi”.
In generale, nel decreto emerge un’impostazione per la quale tra le cause della disoccupazione prevale la difficoltà a fare incontrare domanda e offerta (che pure è un problema reale), anziché la mancanza di opportunità concrete di lavoro (problema ancor più reale).
Questa sovrapposizione tra contrasto alla povertà e politiche attive per il lavoro ha generato un sistema per accedere al Rdc davvero sbagliato. Chi fa domanda e riceve il sussidio, viene inserito in due percorsi distinti: viene inviato al Centro per l’Impiego oppure ai servizi sociali dei Comuni; il primo percorso per i più giovani e disoccupati da minor tempo, il secondo per i più anziani e più “sfortunati”.
Come per il Reddito di Inclusione, una “valutazione preliminare” sulle necessità delle persone e delle loro famiglie, dovrebbe essere fatta invece, per tutti, dai servizi sociali dei Comuni; non solo per chi ha più di 26 anni ed è disoccupato da più di due anni; perché non è detto che anche i soggetti più giovani e da meno tempo disoccupati non abbiano bisogno di altri supporti oltre al sostegno nella ricerca del lavoro.
Se, nel testo del decreto, è chiaro il fatto che i Comuni indirizzano ai Cpi coloro che hanno problemi prevalentemente di tipo lavorativo, non si capisce invece con quale processo i Cpi stessi segnaleranno ai servizi sociali i problemi di tipo sociale e socio-sanitario che riscontreranno in coloro che avranno convocato direttamente perché giovane, o disoccupato da poco.
Il “punto di accesso”, quindi, dovrebbe essere unico ed essere affidato agli ambiti/distretti sociali, destinando ad essi un finanziamento aggiuntivo, proporzionale all’aumento dei soggetti da prendere in carico (il 15% del finanziamento complessivo, come per il Rei); collaborazioni con altre entità, compresi i Caaf, possono essere poi attivate dai servizi sociali. Questo il secondo punto su cui intervenire con modifiche al decreto n.4
Ci sono altri punti da mettere in questione. Primo fra tutti, l’esclusione dal Rdc degli stranieri “lungo soggiornanti”, ma che non possono vantare una residenza da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi: rappresenta una discriminazione che ha chiari profili di incostituzionalità e di violazione del diritto Comunitario, oltre a colpire anche emigrati italiani di ritorno.
Tra l’altro, il numero di famiglie di stranieri oggi destinatarie del Rei, che prevede regole più corrette ed inclusive, è limitato: poco più del 10%. Non si può dire che mantenere il diritto in capo a loro tolga qualcosa ai cittadini italiani.
E ancora, per parametrare il contributo in base alla composizione del nucleo familiare viene utilizzata una scala di equivalenza diversa da quella dell’ISEE, che penalizza in proporzione le famiglie più numerose e quelle che hanno al loro interno dei disabili. Non è un fatto banale, perché il Rdc va speso per forme di consumo, a partire dai generi alimentari, che hanno basse economie di scala: “uno vale uno” per così dire.
Sono previsti incentivi per le imprese: si tratta di un meccanismo complessivamente discutibile, ed in ogni caso di difficile attuazione. Difficile che le imprese comunichino “alla piattaforma digitale dedicata” “i posti vacanti”. Altrettanto, che in tali posti assumano a tempo pieno ed indeterminato soggetti beneficiari di Rdc, “realizzando un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti”.
Sarebbe più utile avere norme di sostegno alla contrattazione collettiva, anche decentrata, per promuovere l’occupazione dei beneficiari del Rdc, mentre nelle situazioni di povertà cronicizzata e di particolare deprivazione, sarebbe necessario incentivare inserimenti lavorativi anche temporanei, sempre che siano seguiti e accompagnati dal tutoraggio dei servizi.
Con il decreto n. 4 vengono cancellati alcuni strumenti di coordinamento istituzionale e di partecipazione delle forze sociali istituiti per il Reddito di inclusione; in particolare non ci sarà più l’organismo in cui era prevista la presenza “delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà”. Così come non è più previsto un Piano nazionale per il contrasto alla povertà. Avevano un senso e lo hanno ancora. Vanno pure ripensati, ma ci devono essere.
Infine, il potenziamento dei Centri per l’Impiego si configura come una operazione significativa di immissione nell’ambito del lavoro pubblico (ma senza certezza di prospettive e con rapporto di lavoro precario, con procedure “semplificate” e possibile oggetto di contenziosi) di personale non necessariamente in possesso delle competenze per accompagnare al lavoro le persone in condizione di povertà o comunque carenti di risorse professionali proprie. Si verificherebbe quello che da decenni si rimprovera ai finanziamenti alle strutture di formazione professionali, utili più a chi lavora nella formazione professionale che alle persone cui sono rivolti i corsi di formazione. In ogni caso, il solo incremento di occupazione certo, nell’immediato, è questo. Bene quindi che, a differenza di quello che è accaduto in passato, si pensi davvero a dare forza ai Centri che devono occuparsi delle politiche attive per il lavoro. Ma non così.
Sul Rdc si sono create molte aspettative, e anche una quota di illusioni. All’uso della “propaganda” da parte del Governo su un tema così delicato e importante non si deve contrapporre altra propaganda. Ma il decreto n. 4 va corretto, in modo significativo, per dare risposte vere alle persone che stanno peggio, e per non buttare via quello che funziona già.